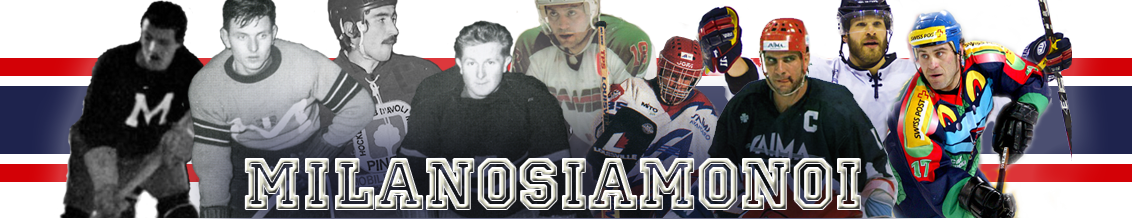di Diego Frigeri
Alle 7 della sera del 19 marzo 2002 suonò il citofono di casa. Consapevole di chi fosse l’interlocutore, mi appropinquai alla cornetta per ascoltare un laconico “scendi”. La voce, dell’Agrario (nome abilmente assegnatogli dal “Faraone”, totem rossoblù, in quanto studente della facoltà di agraria), denotava una malcelata tensione: quella che attanagliava tutti i saimini dal precedente sabato 9 marzo, data di inizio dei play-off. Destinazione Via delle Orchidee, per incontrare il terzo della cricca (noto come “il bolzino”) nella stradina che porta alla scuola primaria “Anemoni”, nostro ritrovo per le partite del Milano, e fare il punto su ciò che ci avrebbe atteso: Milano-Asiago, gara 2 di semifinale play-off.
I martedì milanesi invernali erano ormai un ricordo, il tepore crescente che svelava l’avvicinarsi della primavera era quello tipico che accompagnava i prepartita da “dentro o fuori”. Personalmente, in quella serata, nutrii un senso di nostalgia per alcuni match di regular season privi di pathos “risultatista” che avevano accompagnato quella tribolata stagione: su tutte l’ultimo Milano-Fassa, che pur scarno di contenuti tecnici offrì una rissa da far west scatenata dall’ormai attempato Sergio Liberatore, in grado di svelare – finalmente – l’animus pugnandi dei rossoblù, in particolare di quello di James “Jim” Hiller. Nostalgia che risiedeva nella consapevolezza che una nuova vittoria dell’Asiago avrebbe quasi certamente significato eliminazione.
I volti erano tirati, la sconfitta in gara 1, tenutasi il sabato precedente all’Odegar, era una ferita aperta. Sarebbe stata la grande occasione per ribaltare il fattore campo, contro la squadra che aveva dominato la regular season ed era la grande favorita per vincere il titolo. A maggior ragione contro una compagine che sotto pressione aveva palesato la mancanza di killer istinct (per esempio in avvio di stagione, in Supercoppa proprio contro il Milano, vinta dai rossoblù grazie alla prestazione monumentale del goalie Jason Mark Muzzatti), e che sul piano del gioco, anche per merito di Benoit Laporte, era una spanna sopra tutti. Ogni tentativo di mettere ordine ai miei pensieri e trovare una logica in grado di dominarli fallì miseramente. Quindi, in ordine sparso, come in un fotogramma di un film di Ettore Scola, si palesarono la sorpresa di aver visto la Saima tenere così bene il ghiaccio nel primo episodio della serie. Seguita dal ricordo della clamorosa traversa del difensore milanese Federico Zancanella sul 3-3, poco prima del 60esimo e della lotteria dei rigori. E ancora, il boato dell’Odegar al decisivo penalty del “solito” De Bettin. Cercai di rassicurarmi pensando al peso specifico della nostra prima linea canadese. Di contro, fece capolino lo sconforto per le giocate di assoluto pregio degli attaccanti asiaghesi Houde e Gendron. Provai a calmarmi pensando di avere dalla nostra il casco di Muzzatti, mentre dalla loro vi era quello dell’umorale, nei momenti decisivi, Francois Gravel. Riprovai a trovare equilibrio, aggrappandomi a una delle grandi massime dell’Agrario, colui che mi instillò questa folle passione per l’allora Saima Avandero: ogni partita delle serie play-off vale 1, e la successiva non ha nulla a che vedere con la precedente. Tentativo fallito, cercai allora una terapia d’urto per trovare la necessaria fiducia.
La mia aveva un nome e un cognome: Scott Beattie, da noi soprannominato la “Faina”. Era infatti innata la sua capacità di essere implacabile nei momenti decisivi e cibarsi di quanto avanzava nel traffico dello slot, grazie ad un istinto che gli consentiva di sapere in anticipo quali sarebbero state le anarchie del puck. Ed allora ripensai alla mia presenza alla Disco Arena di Vipiteno per gara 1 dei quarti di finale, prima gara dei play-off di quella, come detto, tormentata stagione. La sua presenza discontinua per i noti problemi familiari era ormai alle spalle. Così come la contestazione di parte del pubblico milanese come conseguenza di risultati in campionato molto deludenti per una squadra che, oltre allo stesso Beattie, in estate aveva acquistato due ex NHLers (Hiller e Muzzatti) e il terzo marcatore della DEL tedesca (Patrice Lefebvre), oltre ad aver puntellato la difesa con gli innesti del prospetto più luminoso dell’hockey italiano (Armin Helfer) e dell’esperto Georg Comploi. Arrivammo in macchina a Vipiteno a metà pomeriggio, circa 3 ore prima dell’inizio del match, che era programmato alle ore 18 di sabato 9 marzo 2002. Dopo circa un’ora arrivò il pullman del Milano. Seduto in prima fila (per intenderci laddove è solito sedersi l’accompagnatore di comitive in escursione) lo stesso Beattie. Cappellino rosso in testa (quello che utilizzava abitualmente solo nei playoff, d’altronde la cabala in post-season non è un vezzo ma un’esigenza) ed uno sguardo talmente concentrato, da capo-branco, che lo scrivente, per incapacità narrativa, non è in grado di descrivere senza scadere in una versione vacua di quanto osservato. La stessa concentrazione mostrata in quell’occasione dai rossoblù, capaci di disinnescare la prima linea del Vipiteno Iob-Beddoes-Gschliesser e di vincere 3-0 in modo cinico, mostrando una solidità poi confermata in una gara 2 dominata, che consentì di chiudere senza patemi la serie.
Rinfrancato, mi incamminai verso lo spazio antistante il palazzo del ghiaccio per l’inizio di gara 2: la temperatura gradevole consentiva ai capannelli di tifosi di esorcizzare “outdoor” la tensione pre-partita. Ci conoscevamo tutti. Ciascuno, pur vivendo intimamente la propria angoscia sportiva, nell’interlocuzione con i restanti fedeli alla causa saimina cercava disperatamente bagliori di ottimismo. Di contro, se quest’ultimo avesse preso il sopravvento, si era pronti a intervenire per interromperne il flusso. Lo scotto, infatti, poteva divenire difficilmente sopportabile: alla meglio, si rischiava di non poter gestire la delusione generata dagli inferi della sconfitta. Alla peggio, a questa si sarebbe aggiunto il senso di colpa per aver gestito con leggerezza il precario rapporto con la sorte, spesso decisiva nei play-off. Ciò che definisco il valzer della tribù rossoblù, laddove l’appartenenza al gruppo che contraddistingue il tifoso, appresa come retaggio di quanto tramandato dagli antenati che popolavano il Piranesi, si mescolavano con le più recondite inconsce paure di Junghiana memoria.
Finalmente l’incontro ha inizio. Viviamo tutti in trance agonistica con la squadra. Il palazzo è un catino, molto più simile allo stadio Velodrome di Marsiglia che ai composti impianti della Bundesliga tedesca. 2 ore e 30 minuti completamente sospesi nel tempo. Sblocca Beattie. Pareggia De Bettin. L’Asiago inizia a spingere. Poi controlla. Infine domina. Rimaniamo aggrappati all’1-1 solo grazie a Muzzatti, più volte decisivo. Ripenso all’occasione persa in gara 1. A metà del terzo periodo è opinione diffusa che l’incontro possa essere vinto dal Milano solo ai rigori. Coach Insam spreme la prima linea, il terzo blocco denominato “delle 3M” (i gemelli Molteni e lo zoldano Meneghetti) non è praticamente più sul ghiaccio. Minuto 59, seconda linea offensiva del Milano in pista. Si perde l’ingaggio e ci posiziona nel solito schema 1-4. Il capitano milanese, Maurizio Bortolussi, prova a fare un ultimo forechecking più di fioretto che di spada, sostanzialmente cercando di rallentare l’uscita di zona della squadra veneta. Succede l’impensabile: Cibien perde il puck, conquistato da Bortolussi nel terzo difensivo dell’Asiago sulla sinistra di Gravel. Il “Moe” finta un “polsino” e sposta il disco sul back, traiettoria alta che non consente il disperato intervento di gambale destro da parte del portiere franco-canadese. Rete. L’Agorà esplode in uno dei boati più assordanti che io abbia mai sentito, a cui partecipo senza pormi alcun limite. In un tripudio di ferocia collettiva, Bortolussi, abbracciata la panchina, pattina verso la curva degli Ultras Milano, mettendosi prima la mano all’orecchio e poi agitando la stecca come fosse una scimitarra, dimostrando di non aver nulla da invidiare ai Persiani che ne facevano uso nell’antichità. È 1-1. Serie in parità. Gioia collettiva.
La mia proseguì tutta la notte successiva, in cui non chiusi occhio per colpa dell’adrenalina che ancora mi dominava. L’indomani, completamente imbelle alla giornata, mi presentai alle 8.30 in università, per la lezione di storia moderna. Simulai di prendere appunti, prassi che avevo per facilitare lo studio. Ma sul foglio, appuntato 13 marzo 2002, in altro a destra comparivano le scritte Beattie-Lefebvre-Hiller/Helfer-Insam, Stevanoni-Zisser-Bortolussi/Uvaev-Comploi, Molteni M-Molteni A-Meneghetti/Rotolo-Zancanella. Forse preoccupato dei minutaggi sostenuti dai giocatori nelle prime 2 partite della serie, sotto la sigla PK2 avevo inserito a rotazione Rotolo, per provare a distribuire meglio lo sforzo tra i difensori in inferiorità numerica. La professoressa scorse la mia assenza (per quanto presentato, non certo per la mia Saima: gara 3 sarebbe stata l’indomani e volevo farmi trovare psicologicamente pronto), ma il suo sguardo non fu severo. Ancora oggi mi chiedo se quella tolleranza fu figlia del mio zelo nel seguire le precedenti lezioni o se, al contrario, lei non fosse già in qualche modo a conoscenza di quello che sarebbe accaduto nelle settimane successive, che avrebbe legittimato la mia distrazione.
Vale a dire una gara 3 vinta dal Milano contro l’Asiago grazie allo shutout di un Muzzatti versione Michigan State, che gli valse la scelta al primo giro del Draft NHL 1988. Una gara 4 soffertissima, in cui Milano, sbloccato il risultato in inferiorità numerica grazie a una magia di Hiller, trasformata in rete da Beattie, si fece rimontare e sorpassare dall’Asiago, per poi pareggiare a pochi minuti dal termine in Power Play e trionfare ai rigori (che non vidi, poiché decisi di non partecipare a quella sofferenza e di uscire dal palazzo, provando a immaginare l’esito di ciascun rigore interpretando i boati del pubblico). Una finale vinta 4-0 contro i resti dell’Alleghe, spremuto all’inverosimile da una serie di semifinale tiratissima contro il Bolzano. La Saima era per la seconda volta campione d’Italia. Potevamo, dopo 11 anni, nuovamente gioire. Tutto, nella mia testa, era nato in quel 19 marzo del 2002.